Macro | 🇨🇳 Guerra e Pace secondo Xi Jinping 🇨🇳
La limpida ambiguità di un leader
Buon rientro, spero abbiate passato una piacevole estate.
Come ogni inizio di settembre, anche quest’anno si svolgerà a Mantova il Festival della letteratura. Personalmente parteciperò a tre eventi. Il primo, questa sera 4 settembre 2025 alle 19, presso Palazzo Sebastiani, dove dialogherò con Alessandro Aresu sul tema “Come l’IA sta ridisegnando il mondo”. Il secondo, venerdì 5 alle 10, in piazza Sordello, dove terrò un keynote di mezz’ora sui temi del mio ultimo libro, Velocissima, intitolato “Da Henry Ford all’auto a guida autonoma”. Infine sabato 6 alle 18.30, presso il Seminario Vescovile discuterò di geopolitica spaziale con Emilio Cozzi.
Dato che siamo in tema di libri e letteratura, colgo l’occasione per ricordarvi la “trilogia industriale” che ho scritto, negli ultimi tre anni, per LUISS University Press e che potete trovare in tutte le librerie e gli e-commerce del “regno”.
Conclusa l’auto-promozione, passiamo al pezzo di oggi, dedicato a Xi Jinping e alla ritrovata bellicosità che ha ostentato negli ultimi giorni.
Pechino. Soldati, carri armati, missili sfilano ordinati come tratti di un ideogramma, sotto lo sguardo ieratico del grande Leader. Un ricordo del periodo di Mao? No. Immagini dell’altro ieri, una parata per celebrare gli ottant’anni dalla conclusione della seconda guerra mondiale in Cina. Al posto del Grande Timoniere, c’è Xi Jinping, imperscrutabile leader di un paese che, secondo proprio Aresu, avrebbe già vinto la partita per il “dominio del secolo”. Accanto a Xi siedono Vladimir Putin e Kim Jong Un, mentre da Washington Donald Trump censura lo spettacolo come una “cospirazione contro gli Stati Uniti”. E, in effetti, la domanda che la scena suscita è semplice e inquietante. Xi sta preparando la Cina alla guerra (e, nel caso, a quale tipo di guerra)? O siamo di fronte a un teatro della potenza che sottintende un linguaggio diverso?
Per capirlo occorre risalire proprio all’evento che la parata celebrava – ovvero la fine della Seconda Guerra Mondiale – una memoria che per Xi e Putin è tanto personale quanto politica. Durante la guerra, la madre di Xi sfuggì per un soffio a una carica di cavalleria giapponese a Pechino, mentre il padre di Putin conobbe fame, ferite e sofferenze nel lungo assedio di Leningrado. Nonostante siano nati dopo la guerra, entrambi gli autocrati ne hanno respirato i miasmi dentro casa. Sono cresciuti nel cono d’ombra del grande trauma del Novecento e l’hanno proiettata nel nuovo secolo. Come raccontava ieri un pezzo di ChinaTalk, da quel trauma, del resto, entrambi traggono le radici della loro narrazione come eredi di una lotta incompiuta contro forze esterne sempre pronte a umiliare i loro paesi.
Da qui l’uso sistematico della storia come strumento di potere. Le memorie della “guerra di resistenza al Giappone” per la Cina e della “Grande guerra patriottica” per la Russia sono usate oggi come serbatoi per sentimenti di rivalsa sempre più diffusi in entrambi i paesi. Film anche molto recenti, monumenti, manuali scolastici rivisti per enfatizzare alcuni episodi e occultarne altri, servono a instillare nelle nuove generazioni un senso di patriottismo revanchista che si nutre, in primis, di paranoie. Guai a contraddirne i dogmi: chi in Russia ridimensiona i sacrifici dell’Armata Rossa, o si azzarda a ricordare l’iniziale intesa tra Stalin e Hitler, viene bollato come “feccia”, mentre in Cina si sorvola sul ruolo marginale che i comunisti di allora ebbero nella guerra contro i giapponesi. Controllare il modo in cui si ricorda il passato significa, del resto, da sempre influenzare il modo in cui si progetta il futuro.
Dietro questa insistenza memoriale c’è un’ulteriore esperienza biografica di fragilità, vissuta in questo caso direttamente. Xi ha visto con i propri occhi il caos della Rivoluzione culturale (come è noto, ne cadde vittima anche il padre) e ha temuto il collasso dello Stato durante le proteste di Tiananmen. Putin ha vissuto l’implosione sovietica come giovane ufficiale del KGB a Berlino Est. Entrambi hanno maturato una convinzione incrollabile: senza un potere forte, i loro paesi rischiano di finire alla merce di un Occidente, percepito e narrato sempre come ipocrita e opportunista. La pace, per loro, non è l’assenza di guerra, ma di caos, in primis all’interno dei loro confini. Il resto, inclusa la pace all’esterno, è secondario.
Ma l’orizzonte in cui questa concezione si muove è più vasto di una parata ed è molto più concreto – politicamente ed economicamente – della retorica in cui è immerso. È l’immenso orizzonte spaziale che va da Mosca a Shanghai, dove ha sede l’OCS (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), un ente fondato nel 2001 e che ormai è arrivato a rappresentare il 42% della popolazione mondiale e quasi un quarto del PIL globale. E non è un caso se la parata di Pechino è stata preceduta, il 31 agosto, da un incontro dell’OCS a Tianjin, a cui ha partecipato, con più entusiasmo del solito, anche Modi. Dietro il linguaggio zuccheroso della “cooperazione win-win” e della “bella casa comune”, i comunicati e le dichiarazioni prodotte dal summit di Tianjin, raccontano di un blocco strategico che si pone, in modo sempre più assertivo e consapevole, l’obiettivo di ridisegnare un mondo “post-occidentale”.
È in questo contesto che l’amicizia tra Xi e Putin assume un significato speciale. Sessanta incontri di persona in poco più di un decennio: più che alleati, quasi compagni di viaggio. La Cina osserva la Russia come un laboratorio: ha visto Gorbačëv fallire nel tentativo di salvare il comunismo, ha visto l’ubriacatura capitalista degli anni Novanta produrre oligarchi e miseria, ha visto Putin ricorrere ai “fantasmi esterni” per stringere di nuovo la società attorno allo Stato. Xi ha scelto finora un’altra via: aprire al mercato, e al dialogo con l’Occidente, senza però mollare il controllo del Partito, puntare su industria, tecnologia e risorse come pilastri della potenza ma reprimendo disuguaglianze e le concentrazioni di eccessivo potere economico.
Oggi però questa strategia sembra giunta a un bivio. La crescita interna, per molti motivi, rallenta, le tensioni sociali in Cina aumentano. E dunque, di fronte alla vertigine del caos, ecco che Xi riprende dalla memoria storica il carburante per un nuovo discorso nazionale, concentrato retoricamente sul “solito” punto: Taiwan. Un tema su cui Xi Jinping è tornato nel corso del suo discorso a margine della parata.
L’isola è insieme simbolo della vittoria incompiuta del 1945 e nodo strategico cruciale. Come raccontato infinite volte qui su Macro, a Taiwan si producono semiconduttori vitali per l’economia globale, per l’industria tecnologica occidentale, per lo sviluppo delle AI.
E tuttavia parlare di un aumento di “bellicosità” di Xi è fuorviante. Le analisi dicono che la Cina non sembra prepararsi a un conflitto immediato, mentre la Storia millenaria della cultura cinese indica che molto raramente essa sceglie la guerra come opzione. Tuttavia, proprio come ha fatto Putin per anni con l’Ucraina, Xi oggi utilizza la retorica del conflitto, il ricordo di quelli passati e lo spettro di quelli futuri, per rafforzare il consenso interno, per guidare il paese verso la sua definitiva affermazione, per rafforzare nuove alleanze, per scoraggiare i rivali globali (USA) e quelli locali (Giappone). La sua è una pace armata, in cui l’equilibrio si regge sull’ostentazione della forza e su una limpida ambiguità in merito all’effettivo ricorso alla suddetta forza.
La domanda è: Xi riuscirà a mantenersi in equilibrio sul sottile filo che corre teatralità e pragmatismo?


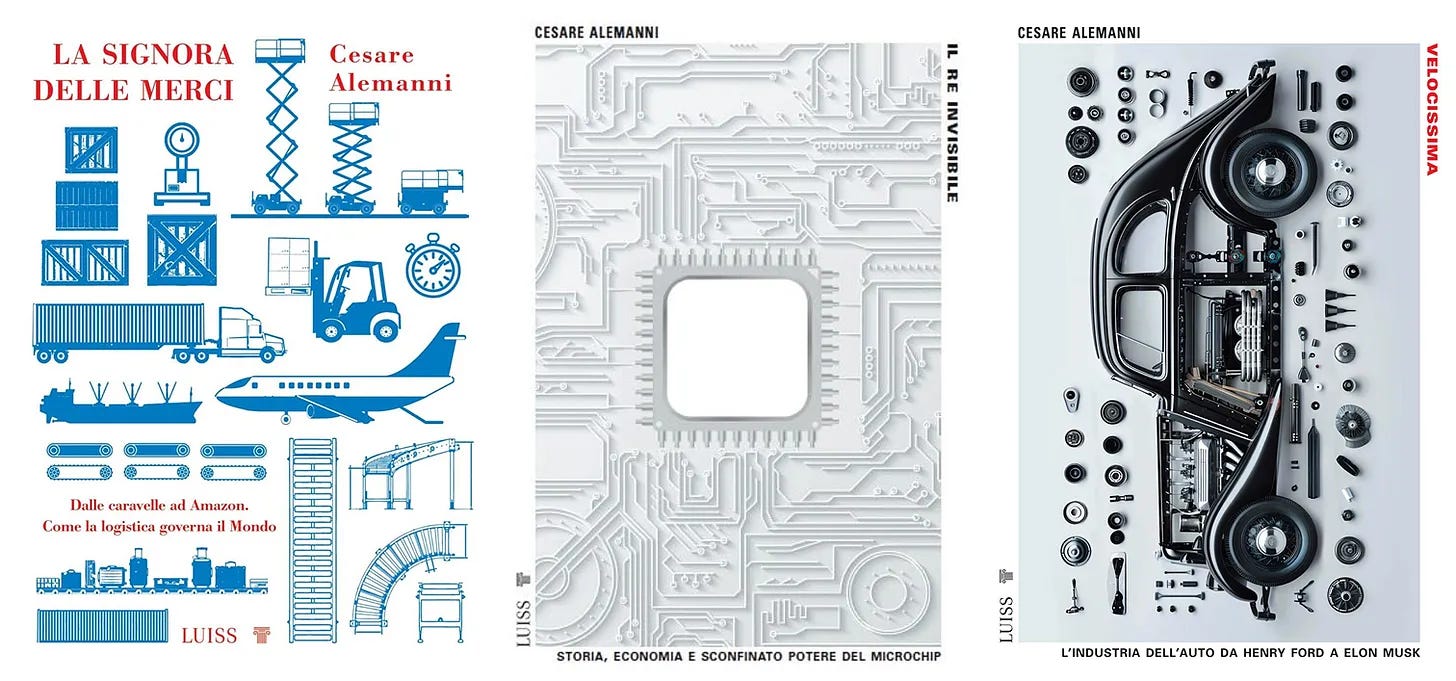

C’è un inquietante ormai mondiale spirito di ritorno al passato, alle sue vittorie, alle sue presunte radici culturali, ai patriottismi che tutte le destre al potere si passano l’un l’altro come un palloncino che può diventare una bomba anche per un solo piccolo litigio internazionale. Se poi le grandi potenze, su larga scala, fanno la stessa cosa invocando gli imperi di un tempo, citando perfino le vittorie della seconda guerra mondiale che però di molti imperi segnò la fine, è evidente che il futuro non sia in buone mani.
Nessuna dittatura è mai stata capace di costruire il futuro, perché ne è la negazione perfetta e affoga in un passato inventato qualunque sogno di progresso sociale e culturale.
Ma noi viviamo in democrazia, dovremmo essere il caposaldo di questa straordinaria conquista e difenderla su tutta la Terra.
Lo siamo, ma quando, attraverso i doni della democrazia, si fa strada anche in Europa, una forma di autocrazia che può diventare una dittatura de facto e se la maggioranza dei cittadini non vede all’orizzonte alternative se non una modesta protesta e nessuna ambiziosa proposta, ecco che arriva una delle peggiori mutazioni genetiche del consenso che si trasforma nel solito pensiero tossico: …”mah visto che il tiro è questo, lo sarà per anni e anni, l’opposizione costruisce poco, alternative non si vedono e dato che la vita è breve, quasi quasi salto sul carro dell’inevitabile vincitore”. E dunque chi o cosa salverà il mondo da queste mostruosità che abbiamo visto arrivare ma che nessuno ha rallentato né, tanto meno,fermato? Se, come diceva il buon Feodor, “la Bellezza salverà il mondo”, questa volta la Bellezza ha un occasione irripetibile per mostrar quello che sa fare.
Dixi et salvavi anima mea, al momento è difficile far di più, temo.