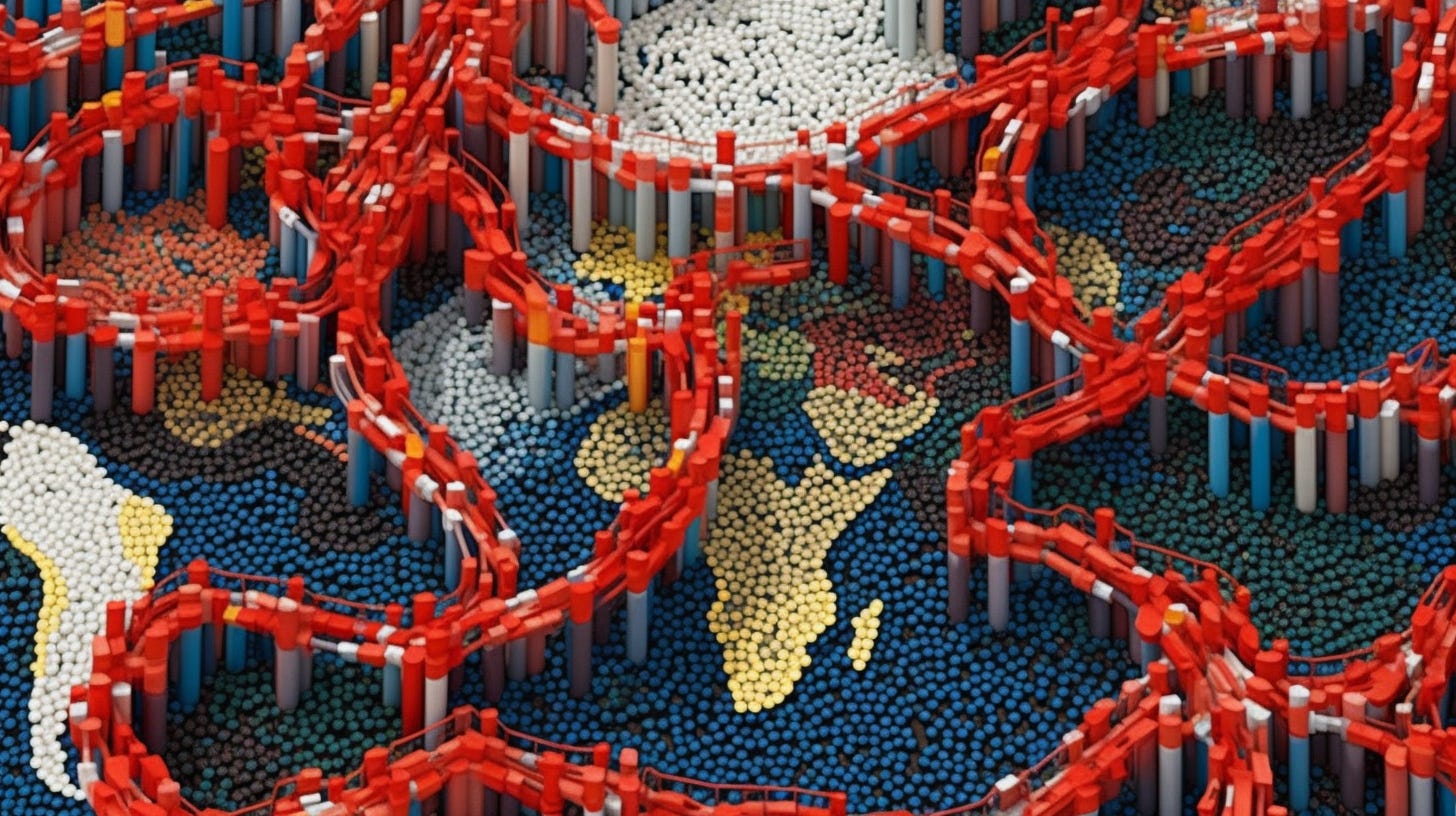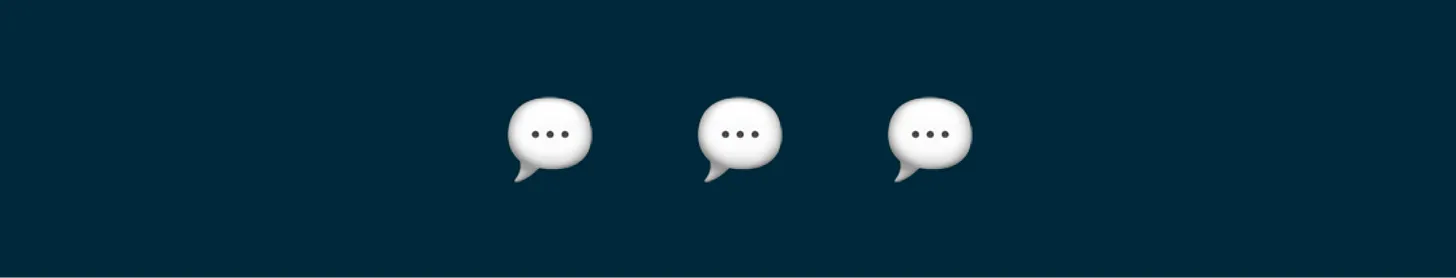La ridefinizione dell’ecosistema economico e industriale globale è uno dei grandi temi di questi anni. Essa è cominciata in coda alla crisi del 2008, ha accelerato al tempo delle “guerre commerciali” di Trump e, negli ultimi anni, è divenuta architrave esplicita della politica economica di Joe Biden. Una politica che tende a due grandi obiettivi. Il primo: ridare fiducia nelle istituzioni alla middle-class americana, che, a torto o a ragione, si ritiene la grande “sconfitta” della globalizzazione e il cui malcontento minaccia di travolgere la stessa democrazia del paese. Il secondo: arrestare l’avanzata della Cina dal punto di vista militare-tecnologico.
Gli americani stanno perseguendo il primo obiettivo con una politica di sussidi e sostegni alla re-industrializzazione, mentre stanno portando avanti il secondo tramite una serie di restrizioni mirate all’export in Cina, specie per quanto riguarda componenti e brevetti strategici per lo sviluppo militare. Dopo un trentennio di evangelizzazione liberale, gli USA sono entrati in una nuova stagione della loro Storia. In cui l’attività economica e commerciale è tornata a essere sussunta all’interno della più ampia categoria del “politico” e a dipendere dalle logiche della sicurezza interna e internazionale.
Principale effetto di questa politica, a cui è stato dato il nome di Bidenomics, è il tentativo di riconfigurare gli imponenti flussi di capitali e cose che avevano animato la (iper)globalizzazione dei ‘90/2000. Questo ha inevitabilmente ricadute sulla struttura di alcune importanti filiere industriali internazionali, le cosiddette catene del valore globale: in alcuni casi con lo scopo di ricollocarle all’interno del territorio americano (si parla in questo caso di reshoring), in altre per accorciarle (nearshoring) o per spostarle in paesi che gli USA considerano alleati o perlomeno più affidabili di Cina, Russia etc (friendshoring). In altre parole stiamo attraversando un periodo d’intensa revisione dei nessi d’interdipendenza economica che hanno legato, negli ultimi decenni, l’Oriente e l’Occidente del mondo.
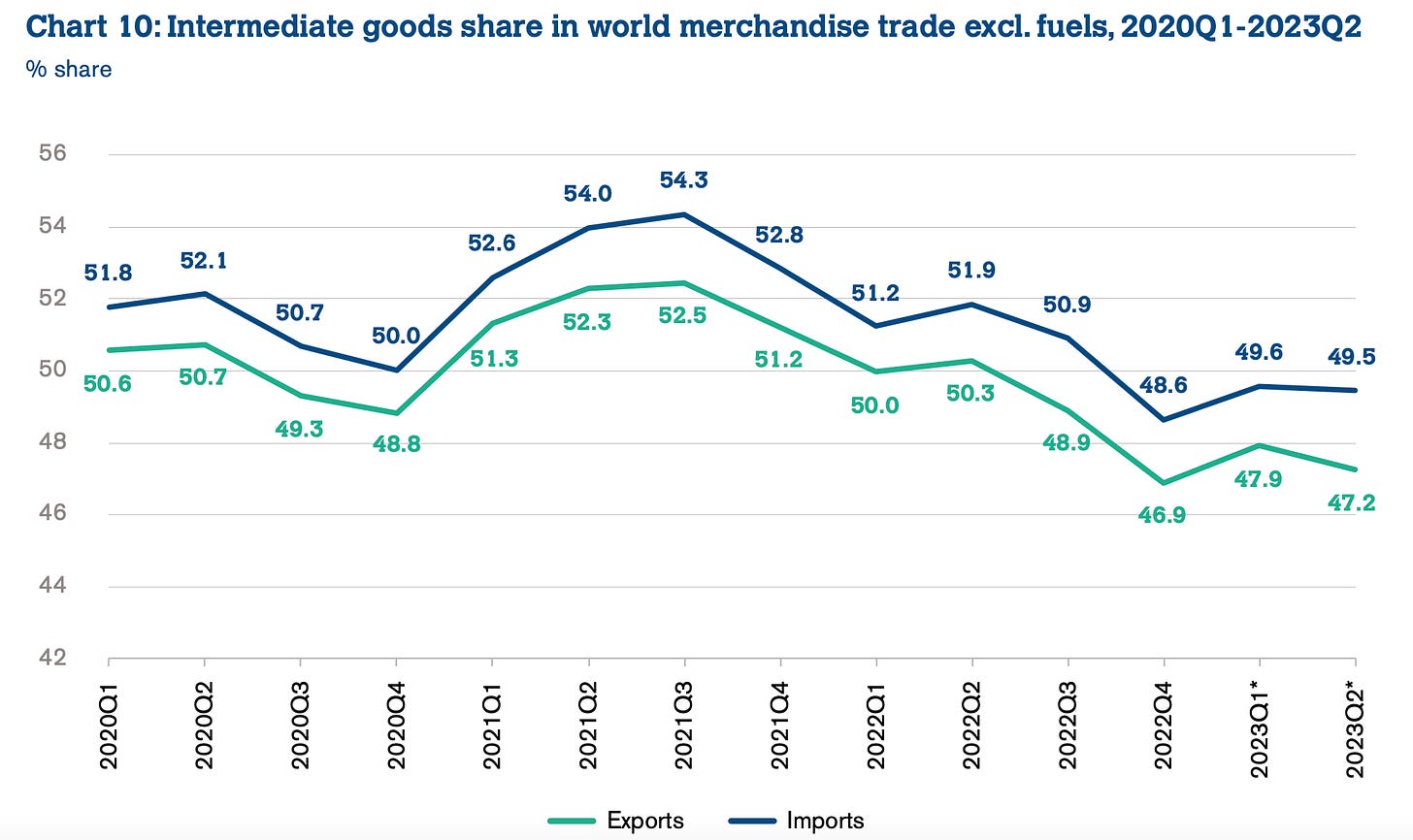
Come spesso accade, quando l’economia politica internazionale si riscalda e i protezionismi tornano a fare capolino, ha preso il via un dibattito sui rischi che la riduzione dei volumi commerciali e la cosiddetta fine della globalizzazione comportano per la stabilità e la pace nel mondo. La questione non nasce dal nulla. Numerosi storici hanno infatti mostrato come, in passato, sul finire della Pax Britannica, a cavallo tra ‘800 e ‘900, l’aumento del protezionismo inglese abbia contribuito a creare le condizioni geo-economiche che portarono alle due guerre mondiali (ci torneremo in una futura lettera). Per non dire della famosa massima di Montesquieu, secondo cui “il naturale effetto del commercio è di portare alla pace”.
Detto che bisognerebbe definire cosa sia commercio, oggi, e chiederci se Montesquieu avrebbe riconosciuto qualcosa di “doux” nella natura ibrida e spesso spietata, a metà tra produzione mobile e interscambio di input produttivi, delle global value chain, è innegabile che da quando la retorica americana sul commercio (cioè circa dal 2017) si è inasprita, il mondo è entrato in un periodo di crescente turbolenza anche politica, sfociata ormai, da quasi due anni, in aperta bellicosità e violenza.
Su questi temi, e in particolare sugli effetti internazionali della Bidenomics, qualche settimana fa il podcast “Rachman Review” del Financial Times ha invitato a esprimersi Nkozi Okonjo-Iweala, la direttrice generale del WTO, l’Organizzazione mondiale del commercio.
Ricorrendo tra l’altro alle argomentazione montesquieiane di cui sopra, in quella sede Nkozi Okonjo-Iweala ha espresso la sua preoccupazione per i recenti sviluppi internazionali e per le aggressivi politiche di sussidi industriali americani. Tuttavia, nel tentativo di alleggerire un po’ l’aria, ha anche aggiunto che la situazione non è senza speranza e che la globalizzazione non va cancellata ma riformulata. Secondo Okonjo-Iweala, il problema con le value chain che gli Stati Uniti, e alcuni loro alleati, stanno cercando di risolvere non ha a che fare con il commercio e con l’inter-dipendenza in senso lato, bensì, in senso stretto, con la “over-dependence” (“iper-dipendenza”) dall’estero, di alcuni settori specifici, e altamente strategici, della produzione internazionale.
La direttrice dell’WTO faceva l’esempio della farmaceutica, in cui il mondo, e l’Occidente in testa, dipende per una quota notevole delle sue scorte di farmaci, e principi attivi, di base da pochi paesi orientali, su tutti India e Cina (ne parlo diffusamente anche nel mio libro). Secondo Okonjo-Iweala, sono questi eccessi di dipendenza, frutto dell’estrema concentrazione di attività produttive particolarmente sensibili in pochi luoghi del pianeta, a rappresentare il vero problema, non l’inter-dipendenza o il commercio in sé.
Sono parole di evidente buon senso. Tuttavia grattando sotto la superficie ci si ritrova a domandarsi quanto un discorso del genere sia saliente rispetto alla natura della questione. È infatti evidente come siano proprio i nessi di iper-dipendenza (o di inter-dipendenza particolarmente strategica) quelli che fanno davvero problema e intorno a cui si concentrano le maggiori tensioni geo-economiche del contemporaneo. Non sono certo le filiere a basso valore aggiunto – per fare un esempio: il tessile – quelle intorno a cui stanno litigando Cina e Stati Uniti. A costituire un problema sono semmai le filiere dei farmaci e quelle dei semiconduttori, i flussi dei metalli rari e l’industria delle batterie elettriche, ovvero proprio le value chains in cui l’uno o l’altro “contendente” ritiene di patire un eccesso di dipendenza dall’altro.
E dunque, sì, ha ragione Okonjo-Iweala, il problema non è l’interdipendenza della globalizzazione, e ad essere “minacciato” non è il commercio internazionale in sé. Tuttavia constatare ciò non garantisce in alcun modo che il tentativo di risolvere i propri problemi di “iper-dipendenza”, da parte delle due super-potenze, non possa essere foriero di ricadute sulla semplice, e innocente, “inter-dipendenza” di filiere all’apparenza innocue. Specie se gli strumenti e le modalità con cui Cina e Stati Uniti intendono confrontarsi continueranno a essere improntate a una logica dell’occhio-per-occhio, come finora è stato. Una logica che potrebbe avere conseguenze disastrose non solo per l’economia di interi paesi ma anche per la stabilità internazionale.
Anziché la solita raccolta di link sul tema della lettera (li trovate direttamente nel testo), raccolgo un po’ di testi che ho pubblicato qui e là in questi ultimi giorni.
Su Appunti di Stefano Feltri ho pubblicato una riflessione sui “costi del mondo diviso” (cit.) e le ricadute sulla produttività globale del surriscaldamento politico in corso, a partire anche dagli spunti forniti dal recente meeting di Marrakech dell’IMF.
C’è persino chi immagina una nuova “cortina di ferro” che separerà il mondo in due sfere, una gravitante intorno alla Cina e l’altra intorno agli Stati Uniti. L’Fmi ha calcolato di recente quanto decrescerebbe l’economia globale in un simile scenario: 7 per cento, come se cancellassimo l’economia tedesca e francese in un colpo solo.
Per Studio ho scritto una recensione di Maniac il saggio-romanzo di Benjamin Labatut sull’influenza intellettuale davvero sconfinata – dalla bomba atomica all’AI – di John von Neumann, uno dei più impressionanti cervelli matematici del XX secolo.
Avete presente espressioni come “il regista che piace ai registi”, ecco von Neumann era il “genio che intimoriva i geni”. Un giorno Enrico Fermi disse a uno studente alle prime armi che tra lui (Fermi) e von Neumann c’era lo stesso gap di comprensione della matematica che esisteva tra quello studente in erba e lo stesso Fermi.
Su Il Tascabile ho pubblicato la recensione di Oltre le banche centrali, il libro in cui l’economista Francesco Saraceno ricostruisce Storia e modalità con cui, a partire dagli anni Settanta, le banche centrali sono assurte a dominatrici della vita finanziaria degli Stati e perché, forse, sarebbe il caso di cominciare a ripensare il raggio della loro influenza.
E, proprio questo, secondo Saraceno, è il problema e la ragione del suo invito ad andare “oltre le banche centrali”. Non solo perché l’affidarsi soltanto alle banche centrali ha effetti collaterali deleteri ma perché affidarsi soltanto alle banche centrali significa togliere dalle spalle della politica e dello Stato una responsabilità che invece dovrebbe essere anche delle politica e dello Stato
Per Quants ho scritto una riflessione, molto divulgativa, sulle ragioni per cui il dollaro è diventato la “valuta internazionale” per eccellenza e sui motivi per cui nonostante oggi questa sua posizione venga sempre più messa in discussione non si facile immaginare un mondo post-dollaro.
Di fatto, oggi, il dollaro è ormai una merce/servizio — un brand a tutti gli effetti — che gli Stati Uniti producono per il resto del mondo. Anche al netto di tutte le criticità che abbiamo esposto, non è detto che qualcuno riuscirà, a conti fatti, a mettere sul mercato un prodotto migliore.
Infine rilancio un pezzo che ho scritto qui su Macro, e a cui tengo particolarmente, in cui cerco di spiegare, in modo “laico”, perché avallare ciò che sta accadendo a Gaza non è solo un azzardo morale da parte dell’Occidente ma anche un grave errore strategico.
E se la reazione degli israeliani può essere comprensibile, e persino giustificabile, in virtù del trauma subito, ipaesi occidentali, incluso il nostro, dovrebbero pensarci due volte prima di fornire sostegno materiale e morale al tipo di guerra che Israele sta conducendo a Gaza. Dovremmo anzi usare la distanza, anche emotiva, dal trauma per aiutare Israele a non imboccare una strada pericolosa in primis per se stesso.
Infine… l’unica registrazione video esistente di von Neumann (sembra incredibile ma è così).