Macro | 💥 Dilemmi nucleari 💥
Alcuni ragionamenti sul ruolo della deterrenza nucleare, nel discorso della geopolitica (e della cultura) contemporanea, a partire dai conflitti in corso.
Negli ultimi anni, la minaccia nucleare è uscita dai film apocalittici per (ri)entrare nei telegiornali. L’attacco di Netanyahu all’Iran – motivato dal programma di arricchimento dell’uranio degli Ayatollah – ha aperto una nuova fase nel conflitto mediorientale. In Ucraina il fantasma atomico è il vero nocciolo “intrattabile” dell’intera questione, ciò che ha reso possibile la cronicizzazione della guerra. Senza la possibilità di agitare lo spauracchio nucleare, la Russia apparirebbe per la tigre di carta che è. E Putin lo sa bene.
La bomba atomica è così tornata a giocare un ruolo attivo nella politica internazionale, proprio come accadeva durante la Guerra Fredda. Il fatto è che quel ruolo è profondamente cambiato.
MAD
Durante la seconda metà del Novecento, l’equilibrio nucleare tra Stati Uniti/NATO e URSS si fondava su un principio semplice: se uno attaccava, l’altro avrebbe risposto, e il risultato sarebbe stata la distruzione di entrambi (e potenzialmente di gran parte delle specie viventi). Questo meccanismo – formalizzato da matematici e teorici in una dottrina nota come mutual assured destruction (MAD) – non escludeva la possibilità del conflitto periferico ma congelava il rischio di una guerra totale tra i due blocchi.
La MAD presupponeva una simmetria pressoché totale tra gli attori coinvolti e i loro potenziali distruttivi, ma il mondo multipolare in cui viviamo è fatto di relazioni asimmetriche, scenari regionali estremamente articolati (che talvolta riproducono, come frattali, simmetrie e schemi di alleanze più grandi ma talaltre no) e soglie di rischio sempre meno chiare.
E così osserviamo che in Ucraina, la Russia sta usando la minaccia nucleare per limitare le opzioni di risposta occidentali che avrebbero probabilmente accelerato la fine della guerra con la sconfitta di Mosca. Putin non ha usato l’arma – anche se è confermato che a ottobre 2022 ci siamo andati vicini – ma, grazie a essa, ha aperto un “ombrello strategico” sotto cui il conflitto ha potuto proseguire per tre anni con modalità che non si vedevano dalla Prima Guerra Mondiale.
Nel caso dell’attacco israeliano all’Iran, il dispositivo del pericolo atomico ha agito in senso diverso, quasi opposto, ovvero precipitando nel presente una minaccia che, fino a quel momento, era rimasta nel futuro.
Israele sta colpendo preventivamente con l’obiettivo dichiarato di impedire all’Iran di acquisire capacità nucleari (anche l’eventuale coinvolgimento degli USA è legato a questo tema, a causa dell’impenetrabilità del sito di Fordow): un’accelerazione della logica della deterrenza per cui non si tratta di scongiurare l’uso della bomba ma impedirne direttamente il suo sviluppo.
E così – portata al suo estremo preventivo – la deterrenza diventa casus belli, la dottrina atomica non è più garanzia di congelamento delle tensioni, ma carburante per la loro proliferazione alle periferie (per ora) degli “imperi”.
Se negli anni della Guerra Fredda la bomba serviva a sublimare i conflitti (con alcune eccezioni regionali eccellenti come il Vietnam per la America o l’Afganistan per l’URSS), oggi viene “usata” per precipitarli (Iran) o per renderli endemici (Ucraina). Anziché dissuadere dall’azione militare, la “nuova” deterrenza la propaga.
La bomba come evento escatologico
L’apparizione della bomba atomica nella storia dell’umanità è un evento profondamente “singolare”. Non solo per la sua effettiva potenza distruttiva, ma per il significato traumatico che da subito ha assunto la sua semplice esistenza: la possibilità concreta della fine dell’umanità e del suo tempo storico. “Now I am become Death, the destroyer of worlds” – la celebre citazione di Oppenheimer – esprime perfettamente il cortocircuito tra razionalità scientifica e terrore religioso che la bomba introdusse nella coscienza moderna.
In un certo senso, la costruzione della bomba atomica è stata l’esito ultimo della traiettoria del positivismo occidentale. La ragione che, portata al suo massimo grado di applicazione, genera la possibilità del suo stesso annientamento. È questo il nucleo escatologico – e per l’appunto la singolarità – dell’atomica: rappresentare un punto oltre il quale tutte le dialettiche della storia e delle civiltà rischiano di dissolversi. È questo anche il suo nucleo strategico, che fa sì che la sua sola “presenza” renda particolarmente “intrattabili” i problemi geopolitici in cui si trova coinvolta. Vedi l’Ucraina.
Durante la Guerra Fredda, questa consapevolezza era profondamente culturale e politicamente intatta. L’ordine mondiale si reggeva sull’idea che la fine fosse possibile in ogni momento, e che proprio tale possibilità avrebbe garantito che non si verificasse. L’orizzonte della catastrofe funzionava come una sorta di sacrario che garantiva equilibrio. La bomba aveva una funzione paradossalmente conservatrice: minacciava la fine per rimandarla.
Di recente, però, qualcosa è cambiato. La minaccia si è logorata. Non perché la sua potenza sia diminuita – anzi – ma la sua percezione si è banalizzata. L’atomica è divenuta un elemento integrato nel “discorso” della politica internazionale contemporanea. Non è più una sacra soglia, ma una variabile strategica discussa come tante altre. L’atomica è ancora capace di distruggere l’umanità, o ampie porzioni di essa, ma questo al massimo suscita qualche meme (uno dei più popolari trend in merito usa come base la copertina di questo articolo e così si spiega anche la sua scelta).
La dottrina della MAD non è mai stata solo calcoli e game theory. A renderla efficace durante la Guerra Fredda era anche una certa aura di tabù. Nell’epoca dello sdoganamento della bomba come argomento da talk show pomeridiano, sembrano rimasti solo i calcoli.
La nebbia dell’escalation
La caratteristica delle crisi di sicurezza da quando esiste l’atomica, è che ogni attore sa che, oltre una certa soglia, si entra in un terreno qualitativamente diverso: quello dell’escalation, coi suoi meccanismi difficilmente controllabili. Questa soglia è una nebbia. Lo è sempre stata ma oggi – nella proliferazione di tensioni prive di chiari centri ordinatori – mancano i sistemi di orientamento.
Un conto è brancolare nella nebbia in due, e usando una mappa su cui ci si è accordati in anticipo, un conto è brancolare in dieci senza ricordare più su cosa ci si era messi d’accordo. La deterrenza classica era fondata su codici, comportamenti e regole d’ingaggio e di comunicazione chiare (se non ci fossero state, durante un paio di crisi, forse non saremmo qui). Oggi tutto ciò sembra superato – come altri aspetti del vecchio sistema – e sostituito da comportamenti opachi e atteggiamenti infantili e para-mafiosi.
Il presente è pericoloso non perché siamo effettivamente più vicini a un conflitto atomico ma perché ogni crisi strategica è già pensata, in anticipo, come crisi nucleare, anche se non lo diventerà mai. Non si tratta più di utilizzare la deterrenza per godere di dividendi di pace, ma di strumentalizzarla per alimentare stati di continua tensione.
Secondo diversi esperti di queste questioni, siamo ormai nell’era della post-deterrenza. Un’epoca in cui l’atomica non serve più a impedire le guerre, ma anzi a renderle possibili.
Il male minore
Il vero rischio non è tanto l’uso della bomba atomica – che resta improbabile, anche se tecnicamente possibile – ma il suo scivolamento nel linguaggio comune, nella routine del discorso politico, nell’estetica persino. È il fatto stesso di parlarne continuamente che produce un effetto di assuefazione morale. Più la bomba entra nel vocabolario della gestione ordinaria, più perde il suo carattere scandaloso. I tabù non crollano per l’uso, ma si consumano nella ripetizione.
Il problema con la banalizzazione culturale della bomba non è tanto che renda più probabile il suo utilizzo ma che relativizzi ogni altra violenza e forma di conflitto. Quando la possibilità di un olocausto nucleare viene trattata come una variabile tra le tante, tutto ciò che sta sotto di essa – cioè ogni altra catastrofe immaginabile – finisce per apparire, tutto sommato, “tollerabile”. È come se l’immagine della distruzione totale risucchiasse tutta l’aria dalla stanza. Se lo scenario peggiore resta confinato alla potenza virtuale della bomba, allora tutto il resto – guerre iper-tecnologiche di trincea, assedi, genocidi a bassa intensità, avventurismi scellerati, vaneggiare di regime change in un paese sviluppato di 90 milioni di persone – può passare sotto il radar.
Scongiurare il male maggiore garantisce l’accettazione di quello minore, ma quello minore diventa, giorno dopo giorno, sempre più grande. La deterrenza, che un tempo serviva a tenere a bada l’impensabile, oggi è divenuta alleata di una cultura della gestione dell’inaccettabile. Dato che nessuno vuole davvero lo scenario finale, tutti sembrano disposti a tollerare qualsiasi cosa “al di qua” di quella soglia.
Se siete nuovi da queste parti, io mi chiamo Cesare Alemanni. Mi interesso di questioni all’intersezione tra economia e geopolitica, tecnologia e cultura. Per Luiss University Press ho pubblicato La signora delle merci. Dalle caravelle ad Amazon, come la logistica governa il mondo (2023), Il re invisibile. Storia, economia e sconfinato potere del microchip (2024) e Velocissima. Storia dell’automobile da Henry Ford a Elon Musk (2025).



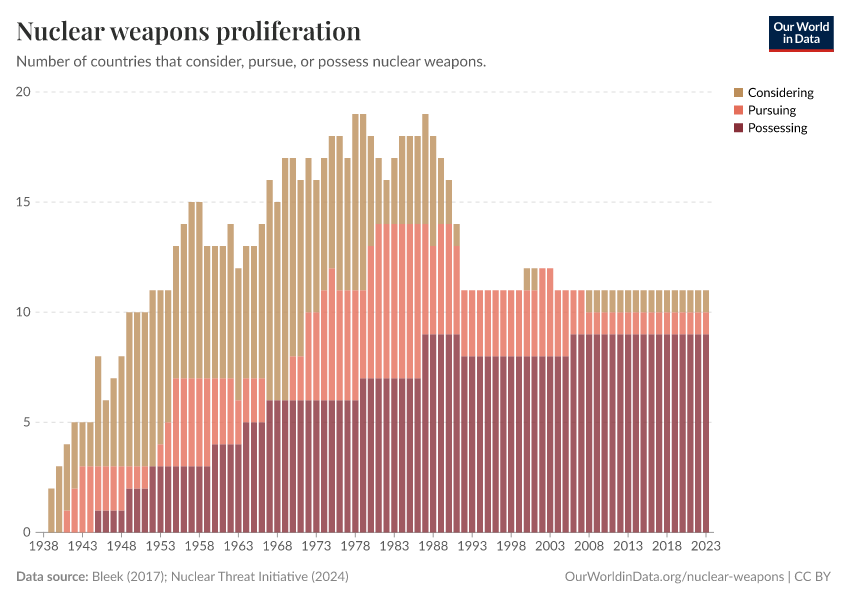




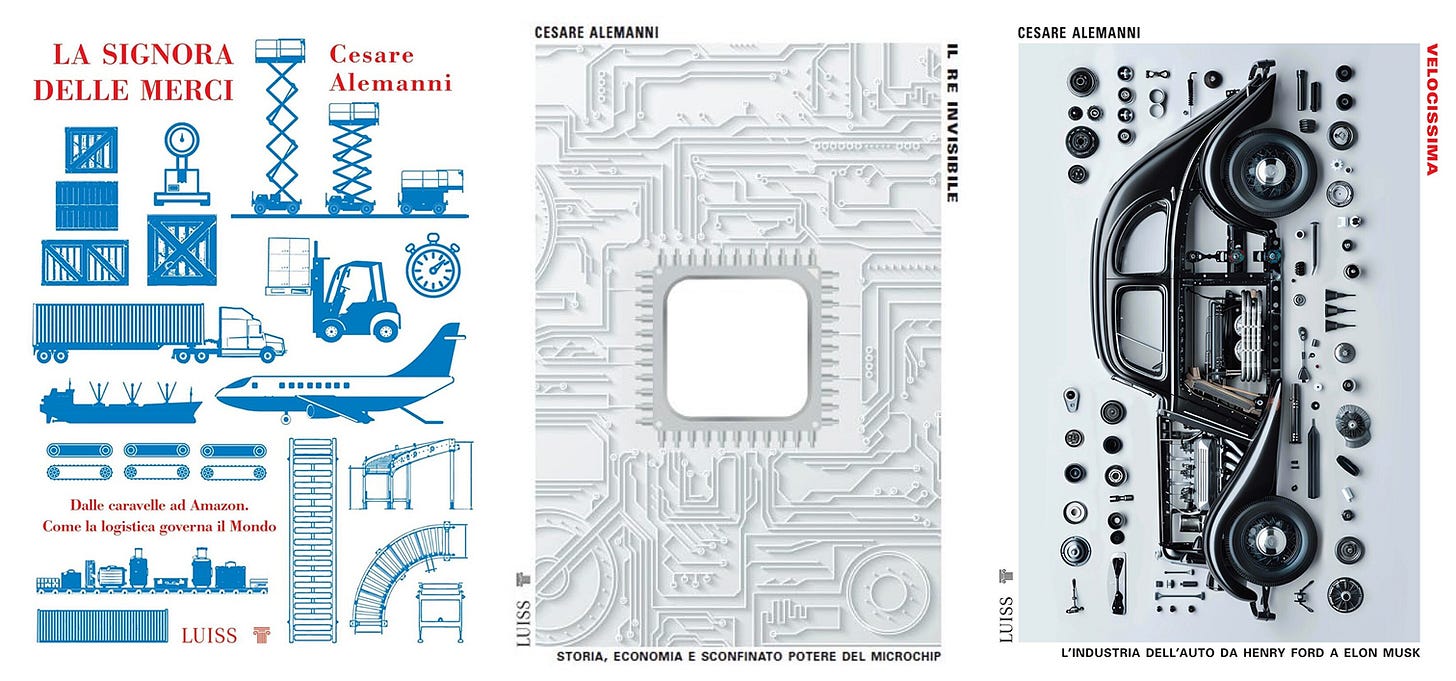
Madonna quant'è vero. INteressantissimo, grazie.
Grazie dottore. Non avevo ancora letto nulla del genere