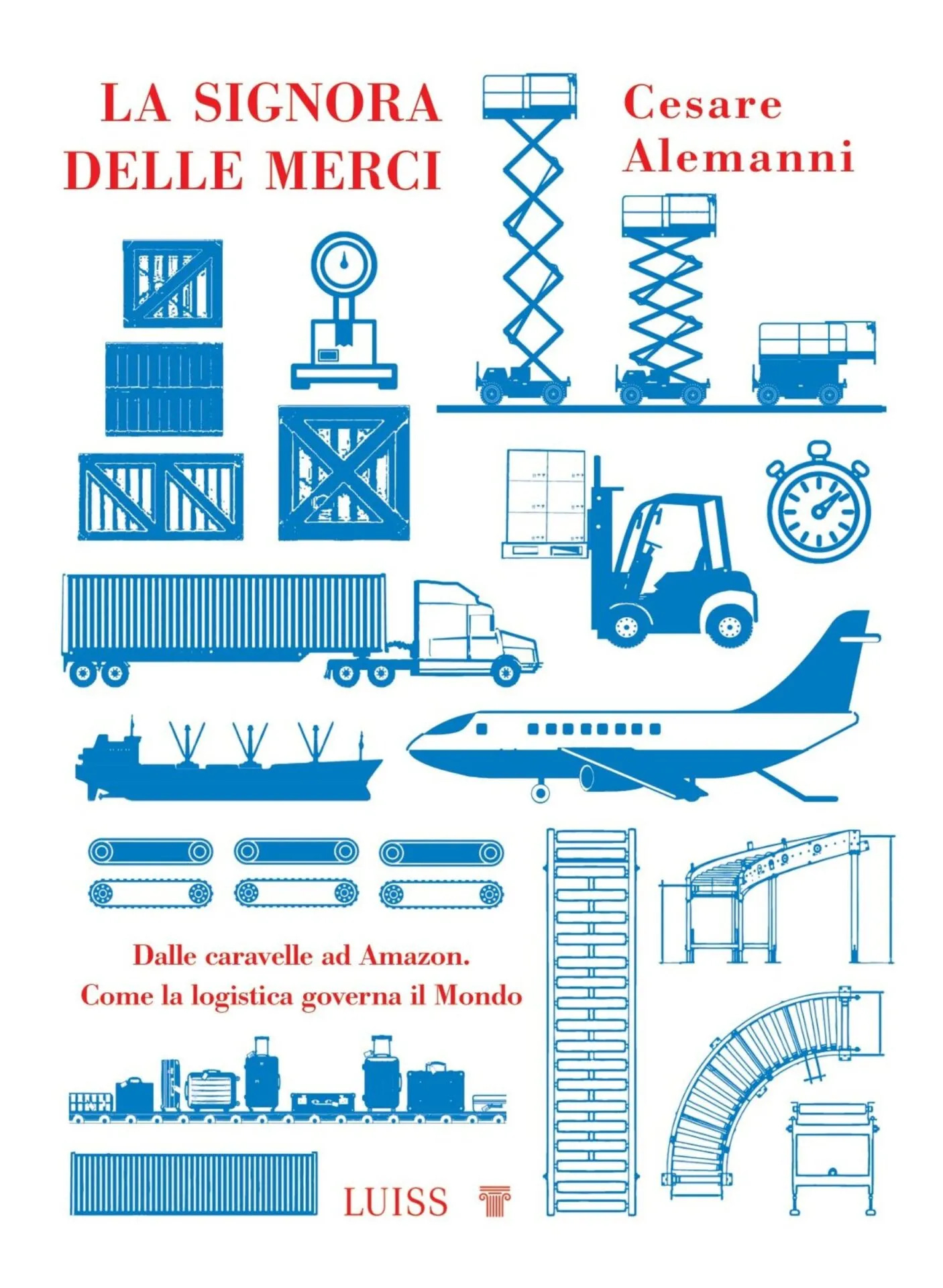Alle due pomeridiane del 6 ottobre del 1973 – 50 anni fa, oggi – gli eserciti di Siria ed Egitto attaccarono, senza preavviso, Israele nel giorno della festa ebraica dello Yom Kippur. Con una mossa a tenaglia – gli egiziani dal Sinai, i siriani dalle alture del Golan – le forze arabe superarono le linee di cessate il fuoco tracciate al termine della Guerra dei sei giorni (1967).
Lo scopo dell’attacco era di vendicare l’umiliazione di sei anni prima, quando gli arabi erano stati ricacciati indietro in meno di una settimana (da cui, appunto, Guerra dei sei giorni), e di recuperare i territori che Israele aveva annesso in quell’occasione (tra cui Sinai e Golan).
La fase cruenta delle ostilità, con la mobilitazione di un milione di soldati, durò poco meno di tre settimane di intensi combattimenti, durante i quali persero la vita quasi 20mila persone. Dopo un’iniziale fase di smarrimento, in cui parve sul punto di capitolare sui due fronti, l’esercito israeliano – sostenuto da aiuti americani come gli arabi dai sovietici – riuscì a rintuzzare l’avanzata nemica e, a partire dal 16 ottobre, iniziò a guadagnare terreno. La mala parata convinse Assad e Sadat ad accettare la tregua proposta dalle Nazioni Unite e, così, il 25 ottobre la guerra si concluse, con l’esercito israeliano che si trovava ormai a meno di 100 chilometri dal Cairo.
L’aver messo in difficoltà Israele, perlomeno inizialmente, consentì ai leader arabi di poter dire di aver rammendato l’orgoglio dopo la disfatta del 1967, mentre Israele uscì dalla guerra senza dover fare concessioni territoriali al nemico.
La conclusione delle ostilità aprì una nuova fase nelle relazioni tra Egitto e Israele. A tempo debito, essa portò agli accordi di Camp David, al riallineamento dell’Egitto fuori dalla sfera sovietica e al primo riconoscimento di Israele da parte di uno stato arabo. La Guerra dello Yom Kippur, come viene oggi ricordata, rappresentò, perciò, un importante capitolo nella storia della questione mediorientale. Questa, tuttavia, è solo una delle ragioni che la rendono uno degli eventi più carichi di ripercussioni globali del dopoguerra.
Per ricostruire le fondamenta su cui si regge una simile affermazione, dobbiamo spostarci dal Medio Oriente alla Mitteleuropa, dal Sinai a Vienna, dove, in quello stesso 6 ottobre 1973, si tenne una riunione dell’OPEC (sopra in foto), l’organizzazione, fondata nel 1960, per promuovere gli interessi economici e politici dei paesi esportatori di petrolio. Con l’eccezione del Venezuela, i membri dell’OPEC, erano tutti paesi arabi o a maggioranza musulmana.
Sebbene l’inerzia del panarabismo nasseriano, che negli anni ‘50 aveva sognato una vera e propria “lega araba”, si fosse dispersa negli anni ‘60, in forza di attriti interni, i paesi dell’OPEC non simpatizzavano certo per Israele. Da tempo, inoltre, numerosi membri dell’organizzazione, Libia e Algeria in testa, sostenevano la necessità di muoversi da cartello, per alzare il prezzo a cui il petrolio veniva venduto alle compagnie occidentali. Qualcuno cominciò addirittura a parlare di “oil weapon”: il petrolio come arma negoziale per ottenere risultati non solo economici ma anche politici.
Il solo capace di tenere a bada tali pressioni era il re saudita Faisal Ibn Adbul Aziz. Riformista, e vicino ad America e Gran Bretagna, Faisal era una sorta di leader in pectore dell’OPEC e, grazie alla sua mediazione, l’Occidente era riuscito a mantenere prezzi di favore per il petrolio. Faisal, tuttavia, era un convinto anti-zionista che, in un’intervista ala NBC, un mese prima del conflitto, aveva dichiarato: “gli americani non possono supportare Israele e avere anche il petrolio a buon mercato. O una o l’altra cosa”.
Nell’autunno del 1973, gli USA erano in pieno scandalo Watergate, e Nixon aveva subappaltato la gestione della politica estera a Henry Kissinger, divenuto Segretario di Stato da un mese. Una delle grandi convinzioni di Kissinger era che la difesa di Israele fosse una delle architravi del sistema di sicurezza americano e, perciò, sottoscrisse senza esitazione l’invio di 2.2 miliardi di aiuti militari all’alleato, sebbene la richiesta della premier israeliana Golda Meir fosse di “soli” 850 milioni.
L’iper-zelo di Kissinger (che, più tardi, egli stesso avrebbe definito “a mistake”) non solo aumentò, di rimbalzo, il coinvolgimento sovietico dall’altra parte, portando gli USA a dichiarare l’allerta nucleare, ma convinse Faisal a cedere ai falchi dell’OPEC e a proclamare, il 17 ottobre, un embargo delle esportazioni di petrolio ai paesi più attivi nel sostegno a Israele: Stati Uniti, Olanda, Giappone, Sudafrica e Portogallo. Nel giro di poche ore, il costo del petrolio si impennò del 70%. Tale impennata fu aggravata dal fatto che, negli anni precedenti, gli USA avevano deciso di rallentare la produzione domestica di greggio (di norma sufficiente al loro fabbisogno) per prediligere le importazioni mediorientali, molto più economiche, e dunque non avevano riserve tali da controbilanciare l’iniziativa araba.

Gli Stati Uniti si erano resi dipendenti dall’esterno per i loro bisogni energetici e pagarono la scelta a caro prezzo. L’Europa scoprì, invece, che, in un mondo post-coloniale, la sua mancanza di risorse fossili era un cruciale elemento di debolezza strategica.
Da un lato all’altro dell’Atlantico si vararono iniziative come le domeniche a piedi e si esortarono le cittadinanze a ridurre i consumi al massimo. I cartelli “benzina esaurita” affissi ai distributori divennero la norma e così via. Alla fine, quando l’OPEC dichiarò concluso l’embargo, nel marzo del 1974, il prezzo del petrolio era passato da 3 a 12 dollari al barile.
Gli impatti, a medio e lungo termine, dell’embargo furono colossali.
Il primo fu, ovviamente, economico. A inizio anni ‘70, le economie occidentali, inclusa quella americana, erano già state messe a dura prova da una persistente inflazione e lo “shock petrolifero”, come venne chiamato, non fece altro che buttare benzina sul fuoco. Decretando la fine dello straordinario periodo di crescita del dopoguerra (i cosiddetti “miracoli economici”), la crisi energetica accelerò il meccanismo che avrebbe portato alla caduta in disgrazia dell’economia politica di scuola keynesiana, aprendo uno spazio di agibilità per nuove idee, incluso il ritorno in auge del liberismo economico.
Complementare a questo fenomeno, ci fu l’ingente trasferimento di ricchezza dalle economie sviluppate ai paesi OPEC. Un flusso di liquidità, i cosiddetti petrodollari, che venne, tra le altre cose, riciclato attraverso il sistema finanziario occidentale e reinvestito, sotto forma di prestiti, in numerosi paesi in via di sviluppo. Già solo questo fatto, di per sé, fu determinante nel dare impulso alla rinascita del settore finanziario americano che, a partire dagli anni ‘30, era stato posto sotto stretto controllo. Una rinascita che, tra liberalizzazioni e flussi di capitale crescenti, non si sarebbe fermata per quasi mezzo secolo.
Di ulteriore importanza fu il fatto che i suddetti prestiti alle economie in via di sviluppo si trasformarono in parte in infrastrutture (logistiche ed industriali) e in parte in debiti insostenibili per i paesi che li ricevettero. Due circostanze che, in combinazione, contribuirono a rendere tali paesi perfettamente funzionali ad accogliere i processi industriali che gli stati OCSE cominciarono a trasferirvi a partire dagli anni ‘80. Furono insomma anche i profitti della crisi petrolifera a finanziare lo “sviluppismo” su cui, in seguito, si sarebbe retta la globalizzazione.
Non meno importanti furono le conseguenze geopolitiche dell’embargo. Esso fece capire agli Stati Uniti la necessità di recuperare l’indipendenza energetica potenziando la produzione domestica, un fatto fondamentale per tutte le loro successive politiche mediorientali, inclusa la seconda guerra in Iraq.
La crisi ricordò invece ai paesi europei che il bassissimo costo del petrolio di cui avevano goduto durante gli anni dei “miracoli economici” era stato solo un residuo privilegio (post)coloniale (frutto, in particolare, delle manovre mediorientali di Churchill). La presa di coscienza di questo fatto contribuì a diffondere la consapevolezza che, non sempre, le visioni del mondo e gli interessi di americani ed europei coincidevano, poiché, tra l’altro, molto diverse erano le dotazioni naturali dei rispettivi territori. A questa consapevolezza si accompagnò la sensazione che la dimensione dello Stato nazionale non fosse più sufficiente per farsi valere nel mondo delle superpotenze. Una consapevolezza che contribuì ad accelerare il tortuoso processo di Unione.
L’effetto più importante tuttavia fu senz’altro quello culturale e simbolico che l’embargo ebbe sugli stessi paesi dell’OPEC e, di riflesso, sul cosiddetto “sud globale”. Dopo secoli di totale assoggettamento coloniale, esso dimostrò che era possibile “colpire” gli occidentali, quantomeno nelle loro tasche. Questa scoperta avrebbe gettato semi destinati a crescere in molte direzioni diverse. Direzioni in alcuni casi costruttive, come la formazione di organizzazioni per tutelare gli interessi dei paesi in via di sviluppo, e, in altri casi, apertamente distruttive, come il finanziamento saudita di organizzazioni terroristiche, inclusa al-Qaeda (peraltro con gli stessi profitti del petrolio).
L’embargo dell’OPEC rappresentò, inoltre, una fondamentale presa di coscienza del fatto che potessero esistere forme di resistenza “autoctone” al potere occidentale che non passavano dall’allineamento col mondo sovietico. Tale consapevolezza sopravvisse alla guerra fredda ed è arrivata fino a noi. Quasi tutti gli storici sono concordi nel dire che il 1973 fu una tappa fondamentale per l’affermarsi dell’aspirazione a un ordine “multipolare” e post-occidentale (ne abbiamo parlato pochi giorni fa).
Un ultimo effetto, assolutamente da non sottovalutare, della crisi del petrolio fu lo sviluppo di una nuova percezione dei consumi energetici. Per la prima volta le persone cominciarono a pensare criticamente in merito e si cominciò a parlare di “risorse alternative” e, in generale, di riduzione dei consumi energetici. Come accaduto in questi ultimi anni, tra covid e guerra in Ucraina, comuni cittadini cominciarono a rendersi conto che le basi materiali delle loro vite erano meno scontate di quanto sembrasse. L’esperienza delle domeniche a piedi e delle città contribuì inoltre alla diffusione di un sentimento ecologista, che proprio in quegli anni aveva trovato prime espressioni e popolarità nei lavori del Club di Roma e in tesi, divenuti a sorpresa bestseller, come The limits to growth e Small is Beautiful.
L’intervista a Re Faisal, di cui si parla nel testo.
Immagini delle prime domeniche a piedi in Italia.
Il libro da leggere sulla storia, politica ed economia, del petrolio è ovviamente The Prize di Daniel Yergin.
Due anni fa, il Times of Israel ha ricostruito il clima di tensione, un atmosfera da vero thriller politico, che si respirava a Gerusalemme nelle ora che precedettero l’invasione dello Yom Kippur.
La guerra dello Yom Kippur fu vicina a sfociare in una escalation nucleare.
Un articolo accademico su “alcune differenze e molte similitudini” tra la risposta europea alla crisi del petrolio del 1973 e a quella del gas russo del 2022.
Un’intervista a Kissinger.
La signora delle merci è il mio secondo libro. È uscito a maggio per LUISS University
Parla del ruolo della logistica e dei grandi trasporti nel mondo di ieri e di oggi. Parla di Amazon e di navi fenicie, di Alessandro Magno e di container, di supply chain e di Spazio, di guerre coloniali e di Repubbliche Marinare, di Keynes e di Friedman.
Parla anche di alcuni degli argomenti di questa lettera: del ruolo della crisi energetica del ‘73 e della finanza dei petrodollari nella trasformazione dei sistemi industriali occidentali e nella successiva globalizzazione, di cui la logistica è stata, ovviamente, un elemento cardine.